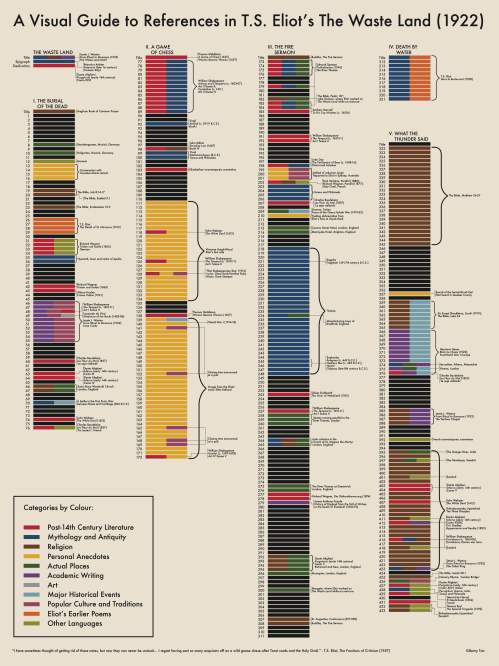V. Van Gogh, Autoritratto sulla strada di Tarascon, 1888 (distrutto durante la seconda Guerra Mondiale)
“…e io facea con l’ombra più rovente
parer la fiamma; e pur a tanto indizio
vidi molt’ombre, andando, poner mente.
Questa fu la cagion che diede inizio
loro a parlar di me: e cominciarsi
a dir: ‘Colui non par corpo fittizio’.”
Dante, Purgatorio, XXVI, vv.7-13
Non rifugiarti nell’ombra
di quel folto di verzura
come il falchetto che strapiomba
fumineo nella caldura.
È ora di lasciare il canneto
stento che pare s’addorma
e di guardare le forme
della vita che si sgretola.
Ci muoviamo in un pulviscolo
madreperlaceo che vibra
in un barbaglio che invischia
gli occhi e un poco ci sfibra.
Pure, lo senti, nel gioco d’aride onde
che impigra in quest’ora di disagio
non buttiamo già in un gorgo senza fondo
le nostre vite randage.
Come quella chiostra di rupi
che sembra sfilacciarsi
in ragnatele di nubi
tali i nostri animi arsi
in cui l’illusione brucia
un fuoco pieno di cenere
si perdono nel sereno
di una certezza: la luce.
E. Montale, Non rifugiarti nell’ombra, in Ossi di seppia, 1925

Glenn Ligon, Untitled (I Sell the Shadow to Support the Substance) 2005, neon sign and paint, Courtesy of Rubell Family Collection, Miami
Maurizio Ferraris, Ogni ombra è illuminata, “La Repubblica”, 25 novembre 2017
Cercare un po’ d’ombra in una giornata calda sembra uno dei pochi valori positivi di questa compagna che non ci abbandona mai, almeno fino a che c’è un po’ di luce. Per il resto, è illusione, come nelle ombre cinesi che rappresentano gli inganni cui sono soggetti gli umani nella Repubblica di Platone, mancanza (della luce, e della cosa che proietta l’ombra), difetto: «siamo un’ombra profonda», diceva Giordano Bruno, e non era un complimento. La presenza dell’ombra in pittura, tuttavia, non è ovvia. Per quanto il termine skiagraphia, pittura con l’ombra, sia greco e si trovi, per esempio, in Platone, non si è riusciti mai a capire che cosa designasse esattamente: un chiaroscuro, una pittura fortemente effettistica, una sorta di stile divisionistico. Sta di fatto che la pittura greca, e in generale quella antica, usa l’ombra con parsimonia, soprattutto quando si tratta dell’ombra portata, quella che una cosa proietta fuori di sé.
Senza dimenticare poi che, in tutte le tradizioni pittoriche in cui prevale la bidimensionalità (la pittura vascolare greca, la pittura egizia, quella cinese, i fumetti), non c’è traccia neppure dell’ombra propria, quella che una cosa proietta su di sé. Però, imparare a guardare le opere partendo dall’ombra è un consiglio che mi sentirei di dare a chiunque. Avremmo infatti non dico un mondo capovolto, ma uno sguardo straniato e illuminante.
Di qui l’importanza del saggio di Ernst Gombrich Ombre. La rappresentazione dell’ombra portata nell’arte occidentale (Einaudi, con una introduzione di John Penny) che accompagnava una mostra alla National Gallery di Londra del 1995, è circoscritta al patrimonio del museo, eppure basta a illustrare le potenzialità e i capovolgimenti che vengono apportati dall’ombra. Le ombre naturali dell’alba e del tramonto nei paesaggi, quelle soprannaturali di Goya, quelle surreali di Pontormo e di de Chirico, quelle indisciplinate di Picasso. E ovviamente le ombre che prevalgono sulla luce, come avviene nei notturni, e nell’esperienza umana ordinaria sino all’invenzione della luce elettrica. Tra le funzioni essenziali dell’ombra, osserva Gombrich, la principale è proprio quella di valorizzare la luce. Restringendosi al patrimonio della National Gallery, l’analisi di Gombrich non può includere il quadro in cui questo principio è realizzato nella forma più alta, La veduta di Delft di Vermeer. Il cielo irregolarmente rannuvolato (una materia affine all’ombra) lascia passare la luce selettivamente. La città si riflette (altra quasi-ombra) nell’acqua, ed è immersa nella penombra. Su questo sfondo opaco si stagliano pochi edifici che sono colpiti in pieno dal sole e, su tutti, a destra, una piccola ala di muro giallo.
Sappiamo l’importanza che questo petit pan de mur jaune riveste nella Recherche di Proust, visto che rappresenta l’azione salvifica dell’arte. Bergotte, lo scrittore, uno dei tanti alter ego del Narratore, che muore felice notando per la prima volta quel giallo emergente dall’ombra.
L’episodio proustiano ci porta a un secondo significato dell’ombra, non solo come mancanza della luce, ma come mancanza della vita, che sta al centro dei poemi in prosa e in poesia di Jorge Luis Borges, l’Elogio dell’ombra (a cura di Tommaso Scarano, Adelphi), pubblicato a settant’anni. Borges vivrà quasi altri due decenni, ma l’ombra attraversa questi scritti in almeno due sensi. Il primo è quello della cecità: Borges era cieco in modo definitivo dal 1955.
Il possibile sottotitolo sarebbe “memorie di un cieco”, il titolo che Derrida diede al suo libro sull’autoritratto. Il cieco a cui Dio (scrive Borges in una poesia non compresa in questa raccolta) ha fatto il dono ambiguo di una massa sterminata di libri e della cecità. Dunque il cieco che tocca e annusa i libri, che li ricorda, che se li fa leggere, ma che non potrà mai più leggerseli da sé. Il secondo è quello della morte. Una lunga tradizione stoica, che si ritrova in Montaigne e a cui aderisce Borges, vuole che imparare a vivere consista nell’imparare a morire.
Ma non sfugge a nessuno l’intrinseca difficoltà di una simile impresa. Ora, Borges suggerisce che l’ombra ci insegni cosa sia la morte, e che proprio per questo va elogiata. Come spesso avviene in Borges, l’elogio sfiora a volte il concettismo, come nel ricordo di Ricardo Güiraldes, morto poco più che quarantenne nel 1927, e autore di Don Secundo Sombra (dunque l’ombra sta, per così dire, in ombra). Altre volte è del tutto esplicito, come in A un’ombra, 1940, in cui Borges prega per l’Inghilterra assediata e invoca l’ombra di De Quincey («mi senti, amico mio non visto, mi senti attraverso quelle cose insondabili che sono i mari e la morte?»).
Tutte le volte che un’ombra si allunga sulla terra, abbiamo un occasione per imparare, se non a morire, a capire che cosa significa, ed è per questo che nel poema conclusivo, che intitola la raccolta, Borges considera la cecità un addestramento alla morte: «Vivo tra forme luminose e vaghe che ancora non sono tenebra». Ed è così che, in una biblioteca illeggibile, Borges propone, attraverso l’esperienza dell’ombra, la versione civile dello stoicismo militare che gli è accaduto spesso di cantare, come negli indimenticabili versi in memoria di Carlo XII di Svezia: «più solo del deserto ardi glaciale; non amasti nessuno e ora sei morto».

Peter Pan, Disney Studios, 1953
WILLIAM CHAPMAN SHARPE, What’s going on in the shadows? A visual arts timeline, 9 novembre 2017. CLICCA QUI.
Presentazione del saggio dello stesso autore Grasping Shadows. The Dark Side of Literature, Painting, Photography, and Film, Oxford University Press, 2017
Whats in a shadow? Menace, seduction, or salvation? Immaterial but profound, shadows lurk everywhere in literature and the visual arts, signifying everything from the treachery of appearances to the unfathomable power of God. From Plato to Picasso, from Rembrandt to Welles and Warhol, from Lord of the Rings to the latest video game, shadows act as central players in the drama of Western culture.
Yet because they work silently, artistic shadows often slip unnoticed past audiences and critics. Conceived as an accessible introduction to this elusive phenomenon, Grasping Shadows is the first book that offers a general theory of how all shadows function in texts and visual media. Arguing that shadow images take shape within a common cultural field where visual and verbal meanings overlap, William Sharpe ranges widely among classic and modern works, revealing the key motifs that link apparently disparate works such as those by Fra Angelico and James Joyce, Clementina Hawarden and Kara Walker, Charles Dickens and Kumi Yamashita.
Showing how real-world shadows have shaped the meanings of shadow imagery, Grasping Shadows guides the reader through the techniques used by writers and artists to represent shadows from the Renaissance onward. The last chapter traces how shadows impact the art of the modern city, from Renoir and Zola to film noir and projection systems that capture the shadows of passers-by on streets around the globe. Extending his analysis to contemporary street art, popular songs, billboards, and shadow-theatre, Sharpe demonstrates a practical way to grasp the dark side that looms all around us.
Frank Sinatra and Sammy Davis Jr, Me and My Shadow, 1962

Jean-Baptiste Regnault, L’origine della pittura, 1785, Olio su tela, Musée National du Château, Versailles
Butade era un vasaio di Corinto. La figlia di Butade era innamorata di un giovane, che però doveva partire e lasciarla. Per perpetuare la sua presenza, la fanciulla, di notte, mentre lui dormiva, tratteggiò il contorno della sua ombra proiettata sul muro al lume di una lanterna. Su queste linee il padre impresse l’argilla, riproducendo i tratti del volto. Nacque il primo ritratto della storia.
Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, XXXV, 151
Roberto Casati, L’ombra. Conferenza – Associazione Nel